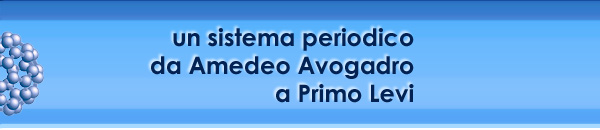|
Ci sono, nell'aria che respiriamo, i cosiddetti gas inerti. Portano
curiosi nomi greci di derivazione dotta, che significano "il
Nuovo", "il Nascosto", "l'inoperoso", "lo
Straniero". Sono, appunto, talmente inerti, talmente paghi
della loro condizione, che non interferiscono in alcuna reazione
chimica, non si combinano con alcun altro elemento, e proprio per
questo motivo sono passati inosservati per secoli: solo nel 1962
un chimico di buona volontà, dopo lunghi ed ingegnosi sforzi,
è riuscito a costringere lo Straniero (lo xenon) a combinarsi
fugacemente con l'avidissimo, vivacissimo fluoro, e l'impresa è
apparsa talmente straordinaria che gli è stato conferito
il Premio Nobel. Si chiamano anche gas nobili, e qui ci sarebbe
da discutere se veramente tutti i nobili siano inerti e tutti gli
inerti siano nobili; si chiamano infine anche gas rari, benché
uno di loro, l'argon, l'inoperoso, sia presente nell'aria nella
rispettabile proporzione dell'1 per cento: cioè venti o trenta
volte più abbondante dell'anidride carbonica, senza la quale
non ci sarebbe traccia di vita su questo pianeta.
Il poco che so dei miei antenati li avvicina a questi gas. Non tutti
erano materialmente inerti, perché ciò non era loro
concesso: erano anzi, o dovevano essere, abbastanza attivi, per
guadagnarsi da vivere e per una certa moralità dominante
per cui "chi non lavora non mangia"; ma inerti erano senza
dubbio nel loro intimo, portati alla speculazione disinteressata,
al discorso arguto, alla discussione elegante, sofistica e gratuita.
Non deve essere un caso se le vicende che loro vengono attribuite,
per quanto assai varie, hanno in comune un qualcosa di statico,
un atteggiamento di dignitosa astensione, di volontaria (o accettata)
relegazione al margine del gran fiume della vita. Nobili, inerti
e rari: la loro storia è assai povera rispetto a quella di
altre illustri comunità ebraiche dell'Italia e dell'Europa.
Pare siano giunti in Piemonte verso il 1500, dalla Spagna attraverso
la Provenza, come sembrano dimostrare alcuni caratteristici cognomi-toponimi,
quali Bedarida-Bédarrides, Momigliano-Montmélian,
Segre (è un affluente dell'Ebro che bagna Lérida,
nella Spagna nord-orientale), Foà-Foix, Cavaglion-Cavaillon,
Migliau-Millau; il nome della cittdina di Lunel, presso le Bocche
del Rodano, fra Montpellier e Nimes, è stato tradotto nell'ebraico
Jaréakh (= luna), e di qui è derivato il cognome ebreo-piemontese
Jarach.
Respinti o male accetti a Torino, si erano stanziati in varie località
agricole del Piemonte meridionale, introducendovi la tecnologia
della seta, e senza mai superare, anche nei periodi più floridi,
la condizione di una minoranza estremamente esigua. Non furono mai
molto amati né molto odiati; non sono state tramandate notizie
di loro notevoli persecuzioni; tuttavia, una parete di sospetto,
di indefinita ostilità, di irrisione, deve averli tenuti
sostanzialmente separati dal resto della popolazione fino a parecchi
decenni dopo l'emancipazione del 1848 ed il conseguente inurbamento,
se è vero quanto mio padre mi raccontava della sua infanzia
a Bene Vagienna: e cioè che i suoi coetanei, all'uscita dalla
scuola, usavano schernirlo (benevolmente) salutandolo col lembo
della giacchetta stretto nel pugno a mo' di orecchio d'asino, e
cantando: "Ôrije 'd crin, ôrije d'asô, a
ji ebreô ai piasô": "orecchie di porco, orecchie
d'asino, piacciono agli ebrei". L'allusione alle orecchie è
arbitraria, ed il gesto era in origine la parodia sacrilega del
saluto che gli ebrei pii si scambiano in sinagoga, quando sono chiamati
alla lettura della Bibbia, mostrandosi a vicenda il lembo del manto
di preghiera, i cui fiocchi, minuziosamente prescritti dal rituale
come numero, lunghezza e forma, sono carichi di significato mistico
e religioso: ma del loro gesto quei ragazzini ignoravano ormai la
radice. Ricordo qui per inciso che il vilipendio del manto di preghiera
è antico come l'antisemitismo: con questi manti, sequestrati
ai deportati, le SS facevano confezionare mutande, che venivano
poi distribuite agli ebrei prigionieri nei Lager.
Come sempre avviene, il rifiuto era reciproco: da parte della minoranza,
una barriera simmetrica era stata eretta contro l'intera cristianità
("gôjfm", "iìarelfm": le "genti",
i "non-circoncisi"), riproducendo, su scala provinciale
e su di uno sfondo pacificamente bucolico, la situazione epica e
biblica del popolo eletto. Di questo fondamentale sfasamento si
alimentava l'arguzia bonaria dei nostri zii ("barba")
e delle nostre zie ("magne"): savi patriarchi tabaccosi
e domestiche regine della casa, che pure si autodefinivano orgogliosamente
"'l pòpôl d'Israél".
Per quanto riguarda questo termine "zio", è bene
avvertire subito che esso deve essere inteso in senso assai ampio.
Fra di noi, è usanza chiamare zio qualunque parente anziano,
anche se lontanissimo: e poiché tutte o quasi le persone
anziane della comunità, alla lunga, sono nostre parenti,
ne segue che il numero dei nostri zii è grande. Nel caso
poi degli zii che raggiungono un'età avanzata (evento frequente:
siamo gente longeva, fino da Noè), l'attributo di "barba",
o rispettivamente di "magna", tende a fondersi lentamente
col nome, e col concorso di ingegnosi diminutivi, e di una insospettata
analogia fonetica tra l'ebraico e il piemontese, si irrigidisce
in appellativi complessi di strano suono, che si tramandano poi
invariati di generazione in generazione insieme con le vicende,
le memorie e i detti di chi li ha a lungo portati. Sono nati così
i Barbaiòtô (zio Elia), Barbasachín (zio Isacco),
Magnaiéta (zia Maria), Barbamòisín (zio Mosè,
di cui si tramanda che si fosse fatto cavare dal ciarlatano i due
incisivi inferiori per poter reggere più comodamente il cannello
della pipa), Barbasmelín (zio Samuele), Magnavigàia
(zia Abigaille, che da sposa era entrata in Saluzzo a cavallo d'una
mula bianca, risalendo da Carmagnola il Po gelato), Magnafòrina
(zia Zefora, dall'ebraico Tzipporà che vale "Uccella":
splendido nome). Ad un'epoca anche più remota doveva appartenere
Nònô Sacòb, che era stato in Inghilterra a comperare
stoffe, e perciò portava "'na vestimenta a quàder":
suo fratello, Barbapartfn (zio Bonaparte: nome tuttora comune fra
gli ebrei, a ricordo della prima effimera emancipazione elargita
da Napoleone), era decaduto dalla sua qualità di zio perché
il Signore, benedetto sia Egli, gli aveva donato una moglie così
insopportabile che lui si era battezzato, fatto frate, e partito
missionario in Cina, per essere il più possibile lontano
da lei.
Nona Bimba era bellissima, portava un boa di struzzo ed era baronessa.
Lei e tutta la sua famiglia li aveva fatti baroni Napoleone, perché
loro "l'aviô prestaie 'd mañòd", gli
avevano imprestato dei soldi.
Barbarònín era alto, robusto e di idee radicali: era
scappato da Fossano a Torino e aveva fatto molti mestieri. Lo avevano
scritturato al Teatro Carignano come comparsa per il Don Carlos,
e lui aveva scritto ai suoi che venissero ad assistere alla prima.
Erano venuti lo zio Natàn e la zia Allegra, in loggione;
quando il sipario si alzò, e la zia vide il figlio tutto
armato come un filisteo, gridò con quanta voce aveva: "Rònín,
co 't fai! Posa côl sàber!": "Aronne, che
fai! Posa quella sciabola!"
Barbamiclín era un semplice; in Acqui veniva rispettato e
protetto, perché i semplici sono figli di Dio e non dirai
loro "raca". Però lo chiamavano Piantabibini, da
quando un rashàn (un empio) si era preso gioco di lui facendogli
credere che i tacchini ("bibini") si seminano come i peschi,
piantandone le penne nei solchi, e crescono poi sui rami. Del resto,
il tacchino aveva un posto curiosamente importante in questo mondo
famigliare arguto, mite ed assestato: forse perché, essendo
presuntuoso, goffo e collerico, esprime le qualità opposte
e si presta a divenire uno zimbello; o forse, più semplicemente,
perché a sue spese si confezionava a Pasqua una celebre semi-rituale
quaiëtta 'd pitô (polpetta di tacchino). Per esempio,
anche lo zio Pacifico allevava una tacchina e le si era affezionato.
Davanti a lui abitava il Signor Lattes che era musicista. La tacchina
chiocciava e disturbava il Signor Lattes; questi pregò lo
zio Pacifico di far tacere la sua tacchina. Lo zio rispose: "Sarà
fàita la sòa cômissiôn. Sôra pita,
c'a staga ciùtô": "Sarà fatta la sua
commissione. Signora tacchina, stia zitta".
Lo zio Gabriele era rabbino, e perciò era noto come "Barba
Morénô", "zio Nostro Maestro". Vecchio
e quasi cieco, se ne tornava a piedi, sotto il sole rovente, da
Verzuolo a Saluzzo. Vide arrivare un carro, lo fermò e chiese
di salire; ma poi, parlando col conducente, a poco a poco si rese
conto che quello era un carro funebre, che portava una morta cristiana
al cimitero: cosa abominevole, perché, come sta scritto in
Ezechiele 44.25, un sacerdote che tocchi un morto, o anche solo
entri nella camera dove giace un morto, è contaminato e impuro
per sette giorni. Balzò in piedi e gridò: "I
eu viagià côn na pegartà! Viturín fermé!":
"Ho viaggiato con una morta! Vetturino fermate!"
Il Gnôr Grassiadiô e il Gnôr Côlômbô
erano due amici-nemici che, secondo la leggenda, abitarono per tempo
immemorabile a fronte a fronte, sui due lati di uno stretto vicolo
della città di Moncalvo. Il Gnôr Grassiadiô era
massone e ricchissimo: si vergognava un poco di essere ebreo, ed
aveva sposato una gôià, e cioè una cristiana,
dai capelli biondi lunghi fino al suolo, che gli metteva le corna.
Questa gôià, benché appunto gôià,
si chiamava Magna Ausilia, il che indica un certo grado di accettazione
da parte degli epigoni; era figlia di un capitano di mare, che aveva
regalato al Gnôr Grassiadiô un grosso pappagallo di
tutti i colori che veniva dalle Guyane, e diceva in latino "Conosci
te stesso". Il Gnôr Côlômbò era povero
e mazziniano: quando arrivò il pappagallo, si era comperata
una cornacchia tutta spelacchiata e le aveva insegnato a parlare.
Quando il pappagallo diceva "Nosce te ipsum" la cornacchia
rispondeva "Fate furb", "fatti furbo".
Ma a proposito della pegartà dello zio Davide, della gôià
del Gnôr Grassiadiò, dei mañòd di Nona
Bimba, e della havertà di cui diremo in seguito, si rende
necessaria una spiegazione. "Havertà" è
voce ebraica storpiata, sia nella forma sia nel significato, e fortemente
pregnante. Propriamente, è un'arbitraria forma femminile
di Havèr = Compagno, e vale "domestica", ma contiene
l'idea accessoria della donna di bassa estrazione, e di credenze
e costumi diversi, che si è costretti ad albergare sotto
il nostro tetto; la havertà è tendenzialmente poco
pulita e scostumata, e per definizione malevolmente curiosa delle
usanze e dei discorsi dei padroni di casa, tanto da obbligare questi
a servirsi in sua presenza di un gergo particolare, di cui evidentemente
fa parte il termine "havertà" medesimo, oltre agli
altri sopra citati. Questo gergo è ora quasi scomparso; un
paio di generazioni addietro, era ancora ricco di qualche centinaio
di vocaboli e di locuzioni, consistenti per lo più di radici
ebraiche con desinenze e flessioni piemontesi. Un suo esame anche
sommario ne denuncia la funzione dissimulativa e sotterranea, di
linguaggio furbesco destinato ad essere impiegato parlando dei gôjím
in presenza dei gôjím; o anche, per rispondere arditamente,
con ingiurie e maledizioni da non comprendersi, al regime di clausura
e di oppressione da essi instaurato.
Il suo interesse storico è esiguo, perché non fu mai
parlato da più di qualche migliaio di persone: ma è
grande il suo interesse umano, come lo è quello di tutti
i linguaggi di confine e di transizione. Esso contiene infatti una
mirabile forza comica, che scaturisce dal contrasto fra il tessuto
del discorso, che è il dialetto piemontese scabro, sobrio
e laconico, mai scritto se non per scommessa, e l'incastro ebraico,
carpito alla remota lingua dei padri, sacra e solenne, geologica,
levigata dai millenni come l'alveo dei ghiacciai. Ma questo contrasto
ne rispecchia un altro, quello essenziale dell'ebraismo della Diaspora,
disperso fra "le genti" (i "gôjim", appunto),
teso fra la vocazione divina e la miseria quotidiana dell'esilio;
e un altro ancora, ben più generale, quello insito nella
condizione umana, poiché l'uomo è centauro, groviglio
di carne e di mente, di alito divino e di polvere. Il popolo ebreo,
dopo la dispersione, ha vissuto a lungo e dolorosamente questo conflitto,
e ne ha tratto, accanto alla sua saggezza, il suo riso, che infatti
manca nella Bibbia e nei Profeti. Ne è pervaso l'yiddisch,
e, nei suoi modesti limiti, lo era anche la bizzarra parlata dei
nostri padri di questa terra, che voglio ricordare qui prima che
sparisca: parlata scettica e bonaria, che solo ad un esame distratto
potrebbe apparire blasfema, mentre è ricca invece di affettuosa
e dignitosa confidenza con Dio, Nôssgnôr, Adonai Eloénô,
Cadòss Barôkhú.
La sua radice umiliata è evidente: vi mancano ad esempio,
in quanto inutili, i termini per "sole", "uomo",
"giorno", "città", mentre vi sono rappresentati
i termini per "notte", "nascondere", "quattrini",
"prigione", "sogno" (ma usato quasi esclusivamente
nella locuzione "bahalòm", "in sogno",
da aggiungere burlescamente ad un'affermazione affinché venga
intesa dal partner, e solo da lui, come il suo contrario), "rubare",
"impiccare" e simili; esiste inoltre un buon numero di
dispregiativi, usati talvolta per giudicare persone, ma impiegati
più tipicamente, ad esempio, fra moglie e marito fermi davanti
al banco del bottegaio cristiano ed incerti sull'acquisto. Citiamo:
"'n saròd", plurale maiestatico, non più
inteso come tale, dell'ebraico "tzarà" = sventura,
ed usato per descrivere una merce od una persona di scarso valore;
ne esiste anche il grazioso diminutivo "saròdín",
e non vorrei andasse dimenticato il feroce flesso "saròd
e senssa mañòd", usato dal sensale di matrimoni
a proposito di fanciulle brutte e senza dote; "hasirúd",
astratto collettivo da "hasír" = maiale, e quindi
equivalente press'a poco a "porcheria, maialume". Si noti
che il suono "u" (francese) non esiste in ebraico; esiste
bensì la desinenza "út" (con "u"
italiana), che serve a coniare termini astratti (ad esempio "malkhút",
regno, da "mélekh", re), ma essa manca della connotazione
fortemente spregiativa che aveva nell'impiego gergale. Altro uso,
tipico ed ovvio, di queste e simili voci era in bottega, fra il
padrone ed i commessi e contro gli avventori: nel Piemonte del secolo
scorso il commercio delle stoffe era sovente in mani ebraiche, e
ne è nato un sotto-gergo specialistico che, trasmesso dai
commessi divenuti a loro volta padroni, e non necessariamente ebrei,
si è diffuso a molte botteghe del ramo e vive tuttora, parlato
da gente che rimane assai stupita quando viene casualmente a sapere
che usa parole ebraiche. Qualcuno, ad esempio, impiega ancora l'espressione
"'na vesta a kiním" per indicare "un vestito
a puntini": ora i "kiním" sono i pidocchi,
la terza delle dieci piaghe d'Egitto, enumerate e cantate nel rituale
della Pasqua ebraica.
Vi è poi un discreto assortimento di vocaboli poco decenti,
da impiegarsi non solo in senso proprio davanti ai bambini, ma anche
in luogo d'improperi: nel qual caso, in confronto coi termini corrispondenti
italiani o piemontesi, essi presentano, oltre al già menzionato
vantaggio di non essere compresi, anche quello di alleviare il cuore
senza scorticare la bocca.
Certamente più interessanti per lo studioso del costume sono
alcuni pochi termini che alludono a cose di pertinenza della fede
cattolica. In questo caso la forma originariamente ebraica è
corrotta molto più profondamente, e ciò per due ragioni:
in primo luogo, la segretezza era qui strettamente necessaria, perché
la loro comprensione da parte dei gentili avrebbe potuto comportare
il pericolo di una incriminazione per sacrilegio; in secondo luogo,
la storpiatura acquista in questo caso il preciso scopo di negare,
di obliterare il contenuto magico-sacrale della parola, e quindi
di sottrarle ogni virtù soprannaturale: per lo stesso motivo,
in tutte le lingue il Diavolo viene designato con moltissimi appellativi
a carattere allusivo ed eufemistico, che permettono di indicarlo
senza proferirne il nome. La chiesa (cattolica) era detta "tônevà",
vocabolo di cui non sono riuscito a ricostruire l'origine, e che
probabilmente di ebraico non ha che il suono; mentre la sinagoga,
con orgogliosa modestia, veniva detta semplicemente "scòla",
il luogo dove si impara e si viene educati, e, parallelamente, il
rabbino non veniva designato col termine proprio "rabbi"
o "rabbénu" (nostro rabbi), ma come Morénô
(nostro maestro), o Khakhàm (il Sapiente). A scòla,
infatti, non si è feriti dall'odioso Khaltrúm dei
gentili: Khaltrúm, o Khantrúm, è il rito e
la bigotteria dei cattolici, intollerabile perché politeistica
e soprattutto perché gremita d'immagini ("Non avrai
altri dèi che me; non ti farai scultura né immagine...
e non la adorerai", Esodo 20.3) e quindi idolatrica. Anche
di questo termine, carico d'esecrazione, l'origine è oscura,
quasi certamente non ebraica: ma in altri gerghi giudeo-italiani
esiste l'aggettivo "khalto", nel senso appunto di "bigotto",
ed usato principalmente a descrivere il cristiano adoratore d'immagini.
A-issà è la Madonna (vale semplicemente "la donna");
del tutto criptico ed indecifrabile, ed era da prevedersi, è
il termine "Odò", con cui, quando proprio non se
ne poteva fare a meno, si alludeva al Cristo, abbassando la voce
e guardandosi attorno con circospezione: di Cristo è bene
parlare il meno possibile, perché il mito del Popolo Deicida
è duro a morire.
Altri numerosi termini erano tratti tali e quali dal rituale e dai
libri sacri, che gli ebrei nati nel secolo scorso leggevano più
o meno speditamente nell'originale ebraico, e spesso comprendevano
in buona parte: ma, nell'uso gergale, tendevano a deformarne o ad
allargarne arbitrariamente l'area semantica. Dalla radice "shafòkh",
che vale "spandere" e compare nel Salmo 79 ("Spandi
la Tua ira sulle genti che non Ti riconoscono, e sopra i regni che
non invocano il Tuo Nome"), le nostre antiche madri avevano
tratto la domestica espressione "fé sefòkh",
fare sefòkh, con cui si descriveva con delicatezza il vomito
infantile. Da "rúakh", plurale "rúkhòd",
che vale "alito", illustre vocabolo che si legge nel tenebroso
e mirabile secondo versetto della Genesi ("Il vento del Signore
alitava sopra la faccia delle acque"), si era tratto "tiré
'n ruàkh", "tirare un vento", nei suoi diversi
significati fisiologici: dove si ravvisa la biblica dimestichezza
del Popolo Eletto col suo Creatore. Come esempio di applicazione
pratica, si tramanda il detto della zia Regina, seduta con lo zio
Davide al Caffè Fiorio in via Po: "Davidín, bat
la cana, c'as sentô nèn le rôkhòd!":
che attesta un rapporto coniugale di intimità affettuosa.
Quanto alla canna, poi, era a quel tempo un simbolo di condizione
sociale, come potrebbe essere oggi il viaggiare in Ia a classe in
ferrovia: mio padre, ad esempio, ne possedeva due, una di bambù
per i giorni feriali, e l'altra di malacca col manico placcato d'argento
per la domenica. La canna non gli serviva per appoggiarsi (non ne
aveva bisogno), bensì per rotearla giovialmente in aria,
e per allontanare dal suo cammino i cani troppo insolenti; come
uno scettro, insomma, per distinguersi dal volgo.
"Berakhà" è la benedizione: un ebreo pio
è tenuto a pronunziarne più centinaia al giorno, e
lo fa con gioia profonda, poiché intrattiene così
il millenario dialogo con l'Eterno, che in ogni berakhà viene
lodato e ringraziato per i Suoi doni. Nonô Leônín
era il mio bisnonno, abitava a Casale Monferrato ed aveva i piedi
piatti; il vicolo davanti alla sua casa era acciottolato, e lui
soffriva a percorrerlo. Un mattino uscì di casa e trovò
il vicolo lastricato, ed esclamò dal profondo del cuore:
"'N abrakhà a côi gôjim c'a l'an fàit
i lòsi!": una benedizione a quegli infedeli che hanno
fatto le lastre. In funzione di maledizione veniva invece usato
il curioso nesso "medà meshônà", letteralmente
"morte strana", ma in effetti calco del piemontese "assidènt".
Allo stesso Nonô Leônín si attribuisce l'imprecazione
inesplicabile "c'ai takèissa 'na medà meshônà
fàita a paraqua", gli prendesse un accidente fatto a
parapioggia.
Né potrei dimenticare Barbaricô, più vicino
nel tempo e nello spazio, tanto che poco è mancato (una sola
generazione) a che egli fosse mio zio nell'accezione ristretta del
termine. Di lui conservo un ricordo personale, e quindi articolato
e complesso, non "figé dans un'attitude" come quello
dei mitici personaggi che finora ho ricordati. A Barbaricô
si addice a pennello la similitudine dei gas inerti con cui incominciano
queste pagine.
Aveva studiato medicina ed era diventato un buon medico, ma non
gli piaceva il mondo. Gli piacevano cioè gli uomini, e particolarmente
le donne, i prati, il cielo: ma non la fatica, il fracasso dei carri,
le mene per la carriera, le brighe per il pane quotidiano, gli impegni,
gli orari e le scadenze; nulla insomma di quello che caratterizzava
la vita affannosa della città di Casale Monferrato nel 1890.
Avrebbe voluto evadere, ma era troppo pigro per farlo. Gli amici
ed una donna, che lo amava e che lui sopportava con distratta benevolenza,
lo convinsero a concorrere per il posto di medico a bordo di un
transatlantico di linea; vinse agevolmente il concorso, fece un
solo viaggio da Genova a Nuova York, ed al ritorno a Genova rassegnò
le dimissioni, perché in America "a j 'era trop bôrdél",
c'era troppo fracasso.
Dopo di allora prese stanza a Torino. Ebbe diverse donne, che tutte
lo volevano redimere e sposare, ma lui riteneva troppo impegnativi
sia il matrimonio, sia uno studio attrezzato e l'esercizio regolare
della professione. Verso il 1930 era un vecchietto timido, rattrappito
e trasandato, paurosamente miope; conviveva con una grossa gôià
volgare, da cui tentava saltuariamente e debolmente di liberarsi,
e che lui definiva volta a volta come "'na sôtià",
"'na hamortà", "'na gran beemà"
(una matta, un'asina, una gran bestia), ma senza acrimonia, ed anzi
con una striatura di inesplicabile tenerezza. Questa gôià
"a vôría fiña félô samdé",
voleva perfino farlo battezzare (letteralmente: distruggere); cosa
che lui aveva sempre rifiutato, non per convinzione religiosa, ma
per mancanza d'iniziativa e per indifferenza.
Barbancò aveva non meno di dodici fratelli e sorelle, che
designavano la sua compagna col nome ironico e crudele di "Magna
Môrfina": ironico perché la donna, poveretta,
in quanto gôià ed in quanto priva di prole, non poteva
essere una magna se non in senso estremamente limitato, e da intendersi
anzi come il suo contrario, di "non-magna", di esclusa
e recisa dalla famiglia; crudele, perché conteneva un'allusione
probabilmente falsa, e comunque impietosa, ad un certo suo sfruttamento
del ricettario di Barbaricò.
I due vivevano in una soffitta di Borgo Vanchiglia, sudicia e caotica.
Lo zio era un ottimo medico, pieno di umana saggezza e d'intuito
diagnostico, ma stava tutto il giorno sdraiato sulla sua cuccia
a leggere libri e giornali vecchi: era un lettore attento, memore,
eclettico ed infaticabile, benché la miopia lo costringesse
a tenere gli stampati a tre dita dagli occhiali, che aveva spessi
come fondi di bicchiere. Si alzava solo quando un cliente lo mandava
a cercare, il che accadeva spesso, perché lui non si faceva
pagare quasi mai; i suoi ammalati erano povera gente della borgata,
da cui accettava come ricompensa mezza dozzina d'uova, o insalata
dell'orto, o magari un paio di scarpe fruste. Dai clienti andava
a piedi, perché non aveva i soldi per il tram; quando in
strada intravvedeva, nella nebbia della miopia, una ragazza, le
si avvicinava, e con sua sorpresa la esaminava accuratamente, girandole
intorno ad un palmo di distanza. Non mangiava quasi niente, e più
in generale non aveva bisogni; morì più che novantenne,
con discrezione e dignità.
Simile a Barbaricò nel suo rifiuto del mondo era Nona Fina,
una di quattro sorelle che tutte si chiamavano Fina: questa singolarità
anagrafica era dovuta al fatto che le quattro bambine erano state
mandate successivamente a Bra dalla stessa balia, che si chiamava
Delfina, e che chiamava così tutti i suoi "bailotti".
Nona Fina abitava a Carmagnola, in un alloggio al primo piano, e
faceva splendidi ricami all'uncinetto. A sessantott'anni ebbe un
lieve malore, una caôdaña, come allora usavano le signore,
ed oggi misteriosamente non usano più: da allora, per vent'anni
e cioè fino alla sua morte, non uscì più dalla
sua camera; al sabato, dal balconcino pieno di gerani, fragile ed
esangue salutava con la mano la gente che usciva da "scòla".
Ma doveva essere stata ben diversa nella sua giovinezza, se è
vero quanto di lei si narra: che cioè, avendole suo marito
condotto a casa come ospite il Rabbino di Moncalvo, uomo dotto ed
illustre, lei gli avesse fatto mangiare a sua insaputa 'na côtlëtta
'd hasír, una costoletta di maiale, perché non c'era
altro in dispensa. Suo fratello Barbaraflín (Raffaele), che
prima della promozione a Barba era noto come 'l fieul 'd Môisé
'd Celín, ormai già in età matura e ricchissimo
per i mañòd guadagnati con le forniture militari,
si era innamorato di una bellissima Dolce Valabrega di Gàssino;
non osava dichiararsi, le scriveva lettere d'amore che non spediva,
e scriveva a se stesso appassionate risposte.
Anche Marchfn, ex-barba, ebbe un'infelice storia d'amore. Si era
innamorato di Susanna (vale "giglio" in ebraico), donna
alacre e pia, depositaria di una secolare ricetta per la confezione
dei salami d'oca: questi salami si fanno utilizzando come involucro
il collo stesso del volatile, e ne è seguito che nel Lassòn
Acòdesh (nella "lingua santa", e cioè nel
gergo di cui ci stiamo occupando) ben tre sinonimi per "collo"
sono sopravvissuti. Il primo, mahané, è neutro e d'uso
tecnico e generico; il secondo, savàr, si usa solo in metafore
quali "a rôta 'd savàr", a rotta di collo:
il terzo, khanèc, estremamente pregnante, allude al collo
come percorso vitale, che può venire ostruito, occluso o
reciso, e si usa in imprecazioni quali "c'at resta ant 'l khanèc",
ti si possa fermare nel gozzo; "khanichésse" vale
"impiccarsi". Di Susanna, dunque, Marchín era commesso
ed aiutante, sia nella misteriosa cucina-officina, sia nella bottega
di vendita, nei cui scaffali erano disposti promiscuamente salami,
arredi sacri, amuleti e libri di preghiere. Susanna lo rifiutò,
e Marchín si vendicò abominevolmente vendendo a un
gòi la ricetta dei salami. È da pensare che questo
gòi non ne abbia apprezzato il valore, dal momento che dopo
la morte di Susanna (avvenuta in epoca storica) non è più
stato possibile trovare in commercio salame d'oca degno del nome
e della tradizione. Per questa sua spregevole ritorsione lo zio
Marchín perdette il diritto ad essere chiamato zio.
Remoto fra tutti, portentosamente inerte, avvolto in uno spesso
sudano di leggenda e d'incredibilità, e fossilizzato per
ogni fibra nella sua qualità di zio, era Barbabramín
di Chieri, zio della mia nonna materna. Ancor giovane era già
molto ricco, avendo acquistato dai nobili del luogo numerose cascine
da Chieri fino all'Astigiano; facendo conto sulla sua eredità,
i suoi parenti sperperarono tutti i loro averi in banchetti, balli
e viaggi a Parigi. Ora avvenne che sua madre, la zia Milca ("Regina"),
si ammalò, e dopo molto contendere col marito si indusse
ad accettare di assumere una havertà, ossia una domestica,
cosa che aveva recisamente rifiutata fino a quel tempo: infatti,
presaga, non voleva donne per casa. Puntualmente, Barbabramín
fu colto d'amore per questa havertà, probabilmente la prima
femmina meno che santa che gli fosse stato dato di avvicinare.
Di costei non è stato tramandato il nome, bensì alcuni
attributi. Era florida e bella, e possedeva splendide khalaviòd
(seni: il termine è sconosciuto all'ebraico classico, dove
tuttavia "khalàv" vale "latte"). Era
naturalmente una gôià, era insolente e non sapeva leggere
né scrivere; era invece un'abilissima cuoca. Era una contadina,
"'na pôñaltà", e andava scalza per
casa. Proprio di tutto questo si innamorò lo zio: delle sue
caviglie, della sua libertà di linguaggio, e dei mangiari
che lei cucinava. Non disse niente alla ragazza, ma dichiarò
a padre e madre che intendeva sposarla; i genitori andarono su tutte
le furie, e lo zio si mise a letto. Ci rimase per ventidue anni.
Su quanto abbia fatto Barbabramín durante questi anni, le
versioni divergono. Non c'è dubbio che li abbia in buona
parte dormiti e giocati: si sa con certezza che andò in rovina
economicamente, perché "non tagliava i cupòn"
dei buoni del Tesoro, e perché aveva affidato l'amministrazione
delle cascine ad un mamsér ("bastardo") che le
aveva vendute per un boccone di pane ad un suo uomo di paglia; secondo
i presagi della zia Milca, lo zio trascinò cosi nella sua
rovina l'intero parentado, ed ancora oggi se ne lamentano le conseguenze.
Si narra anche che abbia letto e studiato, e che, ritenuto infine
sapiente e giusto, ricevesse dal suo letto delegazioni dei notabili
di Chieri e dirimesse controversie; si narra ancora che, di questo
medesimo letto, la via non fosse ignota a quella medesima havertà,
e che almeno nei primi anni la volontaria clausura dello zio fosse
interrotta da sortite notturne per andare a giocare a bigliardo
nel caffè di sotto. Ma insomma a letto rimase, per quasi
un quarto di secolo, e quando la zia Milca e lo zio Salomone morirono,
sposò la havertà e se la portò nel letto definitivamente,
perché era ormai talmente indebolito che le gambe non lo
reggevano più. Morì povero, ma ricco d'anni e di fama,
e in pace di spirito, nel 1883.
La Susanna dei salami d'oca era cugina di Nona Màlia, mia
nonna paterna, che sopravvive in figura di agghindata minuscola
ammaliatrice in alcune pose di studio eseguite verso il 1870, e
come una vecchietta grinzosa, stizzosa, sciatta e favolosamente
sorda nei miei ricordi d'infanzia più lontani. Ancor oggi,
inspiegabilmente, i piani più alti degli armadi restituiscono
suoi preziosi cimeli: scialli di trina nera trapunti di pagliette
iridate, nobili ricami di seta, un manicotto di martora straziato
dalle tignole di quattro generazioni, posate d'argento massiccio
segnate con le sue iniziali: come se, dopo quasi cinquant'anni,
il suo spirito inquieto ancora visitasse la nostra casa.
Ai suoi bei giorni era nota come "la Strassaccoeur", la
stracciacuori: rimase vedova molto presto, e corse voce che mio
nonno si fosse ucciso disperato per le sue infedeltà. Allevò
spartanamente tre figli e li fece studiare: ma in età avanzata
si lasciò sposare da un vecchio medico cristiano, maestoso
barbuto e taciturno, e da allora andò inclinando verso l'avarizia
e la stranezza, quantunque in gioventù fosse stata regalmente
prodiga, come sogliono essere le donne belle e molto amate. Col
passare degli anni si estraniò totalmente dagli affetti famigliari
(che del resto non doveva aver mai sentiti con profondità).
Abitava col Dottore in via Po, in un alloggio fosco e cie-co, intiepidito
d'inverno solo da una stufetta Franklin, e non buttava via più
niente, perché tutto poteva venire a taglio: neppure le croste
del formaggio, né le stagnole dei cioccolatini, con cui confezionava
palle argentate da man-dare alle Missioni "per liberare un
moretto". Forse per timore di sbagliare nella scelta definitiva,
frequentava a giorni alterni la "Scòla" di via
Pio V e la parrocchia di Sant'Ottavio, e pare che andasse addirittura
sacrilegamente a confessarsi. Morì più che ottantenne
nel 1928, assistita da un coro di vicine di casa scarmigliate, nerovestite
e indementite come lei, condotte da una megera che si chiamava Madama
Scílimberg: fra i tormenti del blocco renale, la nonna sorvegliò
la Scílimberg fino al suo ultimo respiro, per timore che
trovasse il maftèkh (la chiave) nascosto sotto il materasso,
e le portasse via i mañôd e i hafassím (i gioielli,
che peraltro risultarono poi tutti falsi).
Alla sua morte, i figli e le nuore si dedicarono per settimane,
con sgomento e ribrezzo, a scegliere la montagna di relitti domestici
da cui l'alloggio era invaso: Nona Màlia aveva conservato,
indiscriminatamente, robe raffinate e pattume rivoltante. Dai severi
armadi di noce intagliato uscirono eserciti di cimici abbagliate
dalla luce, e poi lenzuola di lino mai usate, ed altre rattoppate
e lise, logorate fino alla trasparenza; tendaggi e coperte di damasco
"double face"; una collezione di colibrí impagliati,
che appena toccati si sfecero in polvere; in cantina giacevano centinaia
di bottiglie di vino prezioso girato in aceto. Si ritrovarono otto
mantelli del Dottore, nuovi di zecca, imbottiti di naftalina, e
l'unico che lei gli avesse mai concesso di usare, tutto toppe e
rammendi, col bavero lucido d'untume, ed in tasca uno scudetto massonico.
Non ricordo quasi nulla di lei, che mio padre chiamava Maman (anche
in terza persona), ed amava descrivere con un suo ghiotto gusto
del bizzarro, appena temperato da un velo di pietà filiale.
Mio padre, ogni domenica mattina, mi conduceva a piedi in visita
a Nona Màlia: percorrevamo lentamente via Po, e lui si fermava
ad accarezzare tutti i gatti, ad annusare tutti i tartufi ed a sfogliare
tutti i libri usati. Mio padre era l'Ingegné, dalle tasche
sempre gonfie di libri, noto a tutti i salumai perché verificava
con il regolo logaritmico la moltiplica del conto del prosciutto.
Non che comprasse quest'ultimo a cuor leggero: piuttosto superstizioso
che religioso, provava disagio nell'infrangere le regole del Kasherút,
ma il prosciutto gli piaceva talmente che, davanti alla tentazione
delle vetrine, cedeva ogni volta, sospirando, imprecando sotto voce,
e guardandomi di sottecchi, come se temesse un mio giudizio o sperasse
in una mia complicità.
Quando arrivavamo sul pianerottolo tenebroso dell'alloggio di via
Po, mio padre suonava il campanello, ed alla nonna che veniva ad
aprire gridava in un orecchio: "A l'è 'l prim 'd la
scòla!", è il primo della classe. La nonna ci
faceva entrare con visibile riluttanza, e ci guidava attraverso
una filza di camere polverose e disabitate, una delle quali, costellata
di strumenti sinistri, era lo studio semiabbandonato del Dottore.
Il Dottore non si vedeva quasi mai, né io certo desideravo
vederlo, dal giorno in cui avevo sorpreso mio padre raccontare a
mia madre che, quando gli portavano in cura bambini balbuzienti,
lui gli tagliava con le forbici il filetto sotto la lingua. Arrivati
nel salotto buono, mia nonna cavava da un recesso la scatola dei
cioccolatini, sempre la stessa, e me ne offriva uno. Il cioccolatino
era tarlato, ed io lo facevo sparire in tasca pieno d'imbarazzo.
Nota sulla grafia.
Poiché il gergo descritto è ibrido, ibrida è
anche la grafia a cui ho dovuto ricorrere. Si legga: eu, oeu: come
in francese "peu"; ë: e indistinta o semimuta; h:
leggera aspirazione, come in inglese "home"; kh: forte
aspirazione, come in tedesco "flach"; ñ: n nasale,
come in "fango" e nel piemontese "smaña"o:
come la u italiana; u: come la u francese, per esempio in "plume".
Le altre lettere, come in italiano.
Primo Levi, il sistema periodico, Torino: Einaudi, 1975,
pp. 3-21
|