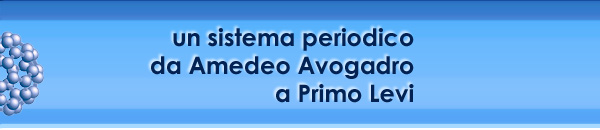|
Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo: suo
fratello era andato in montagna e gli aveva lasciato le chiavi del
laboratorio. Mi vestii in un attimo e lo raggiunsi in strada.
Durante il cammino, appresi che suo fratello non gli aveva propriamente
lasciato le chiavi: era questa una formulazione compendiaria, un
eufemismo, di quelli che si dicono a chi è pronto a capire.
Il fratello, contrariamente al solito, non aveva nascosto le chiavi,
e neppure se le era portate dietro; inoltre, aveva dimenticato di
rinnovare ad Enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi
medesime, e le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto.
Infine ed insomma: le chiavi c'erano, dopo mesi di attesa; Enrico
ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione.
Avevamo sedici anni, ed io ero affascinato da Enrico. Non era molto
attivo, e il suo rendimento scolastico era scarso, ma aveva virtú
che lo distinguevano da tutti gli altri della classe, e faceva cose
che nessun altro faceva. Possedeva un coraggio tranquillo e testardo,
una capacità precoce di sentire il proprio avvenire e di
dargli peso e figura. Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili
discussioni, volta a volta platoniche, darwiniane, bergsoniane più
tardi; non era volgare, non si vantava delle sue capacità
sportive e virili, non mentiva mai. Era consapevole dei suoi limiti,
ma non accadeva mai di sentirgli dire (come tutti ci dicevamo l'un
l'altro, allo scopo di trovare conforto odi sfogare un malumore):
"Sai, credo proprio d'essere un idiota".
Era di fantasia pedestre e lenta: viveva di sogni come tutti noi,
ma i suoi sogni erano saggi, erano ottusi, possibili, contigui alla
realtà, non romantici, non cosmici. Non conosceva il mio
tormentoso oscillare dal cielo (di un successo scolastico o sportivo,
di una nuova amicizia, di un amore rudimentale e fugace) all'inferno
(di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione d'inferiorità
che pareva ogni volta eterna, definitiva). Le sue mete erano sempre
raggiungibili. Sognava la promozione, e studiava con pazienza cose
che non lo interessavano. Voleva un microscopio, e vendette la bicicletta
da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta, e frequentò
la palestra per un anno tutte le sere, senza darsi importanza né
slogarsi articolazioni, finché arrivò ai metri 3,50
che si era prefissi, e poi smise. Più tardi, voile una certa
donna, e la ebbe; volle il danaro per vivere tranquillo, e lo ottenne
dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico.
Non avevamo dubbi: saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni
e speranze erano diverse. Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente,
gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io chiedevo
tutt' altro :per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita
di potenze future, che avvolgeva il mio avvenire in nere volute
lacerate da bagliori di fuoco,simile a quella che occultava il monte
Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge,
l'ordine in me, attorno a me e nel mondo. Ero sazio di libri, che
pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta, e cercavo
un'altra chiave per i sommi veri: una chiave ci doveva pur essere,
ed ero sicuro che, per una qualche mostruosa congiura ai danni miei
e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi somministravano
tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi
riscaldavano le vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare
la mica nel granito, le mie stesse mani, e dicevo dentro di me:
"Capirà anche questo, capirà tutto, ma non come
loro vogliono. Troverò una scorciatoia, mi farò un
grimaldello, forzerò le porte". Era snervante, nauseante,
ascoltare discorsi sul problema dell'essere e del conoscere, quando
tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi: il legno
vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai
tetti, il volo vano dei pappi nell'aria di giugno. Ecco: tutti i
filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci di
costruire questo moscerino? No, e neppure di comprenderlo: questa
era una vergogna e un abominio, bisognava trovare un'altra strada.
Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del
mistero con le nostre forze, col nostro ingegno: avremmo stretto
Proteo alla gola, avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti,
da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel,
da Hegel a Croce. Lo avremmo costretto a parlare.
Questo essendo il nostro programma, non ci potevamo permettere di
sprecare occasioni. Il fratello di Enrico, misterioso e collerico
personaggio di cui Enrico non parlava volentieri, era studente in
chimica, e aveva installato un laboratorio in fondo a un cortile,
in un curioso vicolo stretto e storto che si diparte da piazza della
Crocetta, e spicca nella ossessiva geometria torinese come un organo
rudimentale intrappolato nella struttura evoluta di un mammifero.
Anche il laboratorio era rudimentale: non nel senso di residuo atavico,
bensí in quello di estrema povertà. C'era un bancone
piastrellato, poca vetreria, una ventina di bocce con reattivi,
molta poi vere, molte ragnatele, poca luce e un gran freddo. Lungo
tutta la strada avevamo discusso su quello che avremmo fatto, ora
che saremmo "entrati in laboratorio", ma avevamo idee
confuse.
Ci sembrava "embarras de richesse", ed era invece un altro
imbarazzo, piú profondo ed essenziale: un imbarazzo legato
ad un'antica atrofia, nostra, delle nostre famiglie, della nostra
casta. Cosa sapevamo fare con le nostre mani? Niente, o quasi. Le
donne sí: le nostre madri e nonne avevano mani vive ed agili,
sapevano cucire e cucinare, alcune anche suonare il piano, dipingere
con gli acquerelli, ricamare, intrecciarsi i capelli. Ma noi, e
i nostri padri?
Le nostre mani erano rozze e deboli ad un tempo, regredite, insensibili:
la parte meno educata dei nostri corpi . Compiute le prime fondamentali
esperienze del gioco, avevano imparato a scrivere e null'altro.
Conoscevano la stretta convulsa intorno ai rami degli alberi, su
cui amavamo arrampicarci per voglia naturale ed insieme (Enrico
ed io) per confuso omaggio e ritorno all'origine della specie; ma
ignoravano il peso solenne e bilanciato del martello, la forza concentrata
delle lame, troppo prudentemente proibite, la tessitura sapiente
del legno, la cedevolezza simile e diversa del ferro, del piombo
e del rame. Se l'uomo è artefice, non eravamo uomini: lo
sapevamo e ne soffrivamo.
Il vetro del laboratorio ci incantava e ci intimidiva. Il vetro,
per noi, era ciò che non si deve toccare perché si
rompe, e invece, ad un contatto piú intimo, si rivelava una
materia diversa da tutte, di suo genere, piena di mistero e di capriccio
simile in questo all'acqua, che pure non ha congeneri: ma l'acqua
è legata all'uomo, anzi alla vita, da una consuetudine di
sempre, da un rapporto di necessità molteplice, per cui la
sua unicità si nasconde sotto la veste dell'abitudine. Il
vetro, invece, è opera dell'uomo ed ha storia piú
recente. Fu la prima nostra vittima, o meglio il primo nostro avversario.
Nel laboratorio della Crocetta c'era tubo di vetro da lavoro, di
vari diametri, in mozziconi lunghi e corti, tutti coperti di polvere:
accendemmo un becco Bunsen e ci mettemmo a lavorare.
Piegare il tubo era facile. Bastava tenere fermo uno spezzone sulla
fiamma: dopo un certo tempo la fiamma diventava gialla, e simultaneamente
il vetro si faceva debolmente luminoso. A questo punto il tubo si
poteva piegare: la curva che si otteneva era ben lontana dalla perfezione,
ma in sostanza qualcosa avveniva, si poteva creare una forma nuova,
arbitraria; una potenza diventava atto, non era questo che intendeva
Aristotele?
Ora, anche un tubo di rame o di piombo si può piegare, ma
ci accorgemmo presto che il tubo di vetro arroventato possedeva
una virtú unica: quando era diventato cedevole si poteva,
allontanando rapidamente i due tronconi freddi, tirarlo in filamenti
molto sottili, anzi, sottili oltre ogni limite, tali da essere trascinati
verso l'alto dalla corrente d'aria calda che saliva dalla fiamma.
Sottili e flessibili, come la seta. Ma allora, dove era scomparsa
la rigidità spietata del vetro massiccio? Allora, anche la
seta, anche il cotone, se si potessero ottenere in forma massiccia,
sarebbero inflessibili come il vetro? Enrico mi raccontò
che al paese di suo nonno i pescatori usano prendere i bachi da
seta, quando sono già grossi, e, desiderosi di imbozzolarsi,
si sforzano ciechi e goffi di inerpicarsi su per i rami; li prendono,
li spezzano in due con le dita, e tirando i tronconi ottengono un
filo di seta, grosso e rozzo, resistentissimo, che usano poi come
lenza. Il fatto, a cui non esitai a credere, mi appariva ad un tempo
abominevole ed affascinante: abominevole per il modo crudele di
quella morte, e per il futile uso di un portento naturale; affascinante
per lo spregiudicato e audace atto d'ingegno che esso presupponeva
da parte del suo mitico inventore.
Il tubo di vetro si poteva anche soffiare: questo però era
molto meno facile. Si riusciva a chiudere l'estremità di
un tubetto: soffiando poi con forza dall'altra estremi
tà si formava una bolla, assai bella a vedersi e quasi perfettamente
sferica, ma dalle pareti assurdamente sottili. Per poco che si eccedesse
nel soffiare, le pareti assumevano l'iridescenza delle bolle di
sapone, e questo era un segno sicuro di morte: la bolla scoppiava
con un colpetto secco, e i frammenti si disperdevano a terra con
un tenue brusio di cocci d'uovo. In qualche modo, era una giusta
punizione; il vetro è vetro, e non avrebbe dovuto simulare
il comportamento dell'acqua saponata. Forzando un poi termini, si
poteva ravvisare nella vicenda un apologo esopiano.
Dopo un ora di lotta col vetro, eravamo stanchi ed umiliati. Avevamo
entrambi gli occhi infiammati ed aridi per il troppo guardare il
vetro rovente, i piedi gelati e le dita piene di scottature. D'altronde,
lavorare il vetro non è chimica: noi eravamo in laboratorio
con un altro scopo. Il nostro scopo era quello di vedere coi nostri
occhi, di provocare con le nostre mani, almeno uno dei fenomeni
che si trovavano descritti con tanta disinvoltura sul nostro testo
di chimica. Si poteva, per esempio, preparare l'ossidulo d'azoto,
che sul Sestini e Funaro era ancora descritto col termine poco proprio
e poco serio di gas esilarante. Sarebbe proprio stato esilarante?
L'ossidulo d'azoto si prepara riscaldando cautamente il nitrato
d'ammonio. Quest'ultimo, nel laboratorio, non esisteva: esistevano
bensí ammoniaca ed acido nitrico. Li miscelammo, incapaci
di fare calcoli preventivi, fino a reazione neutra al tornasole,
per il che la miscela si riscaldò fortemente ed emise abbondanti
fumi bianchi; poi decidemmo di farla bollire per eliminare l'acqua.
Il laboratorio si riempí in breve di una nebbia irrespirabile,
che non era esilarante per nulla; interrompemmo il tentativo, per
nostra fortuna, perché non sapevamo che cosa può accadere
a scaldare questo sale esplosivo meno che cautamente.
Non era né semplice, né troppo divertente. Mi guardai
intorno, e vidi in un angolo una comune pila a secco. Ecco quanto
avremmo fatto: l'elettrolisi dell'acqua. Era un'esperienza di esito
sicuro, che avevo già eseguito varie volte a casa: Enrico
non sarebbe stato deluso.
Presi acqua in un becher, vi sciolsi un pizzico di sale, capovolsi
nel becher due barattoli da marmellata vuoti, trovai due fili di
rame ricoperti di gomma, li legai ai poli della pila, e introdussi
le estremità nei barattoli. Dai capi saliva una minuscola
processione di bollici ne: guardando bene, anzi, si vedeva che dal
catodo si liberava su per giú il doppio di gas che dall'anodo.
Scrissi sulla lavagna l'equazione ben nota, e spiegai ad Enrico
che stava proprio succedendo quello che stava scritto lí.
Enrico non sembrava tanto convinto, ma era ormai buio, e noi mezzo
assiderati; ci lavammo le mani, comperammo un po' di castagnaccio
e ce ne andammo a casa, lasciando che l'elettrolisi continuasse
per proprio conto,
Il giorno dopo trovammo ancora via libera. In dolce ossequio alla
teoria, il barattolo del catodo era quasi pieno di gas, quello dell'anodo
era pieno per metà: lo feci notare ad Enrico, dandomi piú
importanza che potevo, e cercando di fargli balenare il sospetto
che, non dico l'elettrolisi, ma la sua applicazione come conferma
alla legge delle proporzioni definite, fosse una mia invenzione,
frutto di pazienti esperimenti condotti nel segreto della mia camera.
Ma Enrico era di cattivo umore, e metteva tutto in dubbio. Chi ti
dice poi che sia proprio idrogeno e ossigeno? mi disse con malgarbo.
E se ci fosse del cloro? Non ci hai messo del sale?
L'obiezione mi giunse offensiva: come si permetteva Enrico di dubitare
di una mia affermazione? Io ero il teorico, solo io: lui, benché
titolare (in certa misura, e poi solo per " transfert")
del laboratorio, anzi, appunto perché non era in condizione
di vantare altri numeri, avrebbe dovuto astenersi dalle critiche.
Ora vedremo, dissi: sollevai con cura il barattolo del catodo, e
tenendolo con la bocca in giú accesi un fiammifero e lo avvicinai.
Ci fu una esplosione, piccola ma secca e rabbiosa, il barattolo
andò in schegge (per fortuna lo reggevo all'altezza del petto,
e non piú in su), e mi rimase in mano, come un simbolo sarcastico,
l'anello di vetro del fondo.
Ce ne andammo, ragionando sull'accaduto. A me tremavano un po' le
gambe; provavo paura retrospettiva, e insieme una certa sciocca
fierezza, per aver confermato un'ipotesi, e per aver scatenato una
forza della natura. Era proprio idrogeno, dunque: lo stesso che
brucia nel sole e nelle stelle, e dalla cui condensazione si formano
in eterno silenzio gli universi.
Primo Levi, il sistema periodico, Torino: Einaudi, 1975,
pp. 22-29.
|