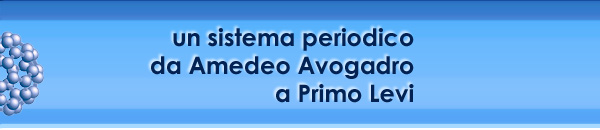|
Benché il loro mestiere sia piú recente che quello
dei teologi, dei vignaioli o dei pescatori, anche i chimici, fin
dalle loro origini, hanno sentito la necessità di dotarsi
di un loro linguaggio specializzato. Tuttavia, a differenza dagli
altri linguaggi di mestiere, quello dei chimici ha dovuto adattarsi
ad un servizio che credo unico nel panorama degli infiniti gerghi
specialistici: deve poter indicare con precisione, e possibilmente
descrivere, piú di un milione di oggetti distinti, poiché
tanti sono (e crescono ogni anno) i composti chimici rinvenuti in
natura o costruiti per sintesi.
Ora, la chimica non è nata intera come Minerva, bensí
faticosamente, attraverso le prove e gli errori pazienti ma ciechi
di tre generazioni di chimici che parlavano lingue diverse e che
spesso comunicavano fra loro solo per lettera; perciò, la
chimica del secolo scorso si è andata consolidando attraverso
una terribile confusione di linguaggi, i cui resti persistono nella
chimica di oggi. Lasciamo da parte per ora la chimica inorganica,
che ha problemi relativamente piú semplici e che merita un
discorso a parte. Nella chimica organica, cioè nella chimica
dei composti del carbonio, confluiscono almeno tre diversi modi
di esprimersi.
Il piú antico è anche il piú snello e pittoresco;
consiste nel dare ad ogni nuovo composto scoperto un nome di fantasia,
che ricordi il prodotto naturale da cui esso è stato per
la prima volta isolato: nomi come geraniale, carotene, lignina,
asparagina, acido abietico, esprimono abbastanza bene (per noi neolatini!)
l'origine della sostanza, ma non dicono niente sulla sua costituzione.
E già piú oscura, anche per noi, l'adrenalina, che
è stata chiamata cosí perché isolata dalle
capsule surrenali ("ad renes", vicino ai reni). Anche
la benzina trae il suo nome (italiano e tedesco: altre lingue la
chiamano diversamente) da un prodotto naturale, ma attraverso una
storia chimico-linguistica strana e ingarbugliata. All 'inizio c
e il benzoino, resina profumata che da almeno duemila anni viene
importata dalla Thailandia e da Sumatra, e che un tempo veniva usata
non solo in profumeria, ma anche in terapia: non so con quale fondamento,
forse solo in base al pericoloso ragionamento secondo cui le sostanze
che hanno odore grato devono "far bene". Il commercio
di questa resina, e di molte altre spezie, era in mano ai mercanti
e navigatori arabi. Poiché lo spirito pubblicitario, ed insieme
la protezione dei segreti commerciali, sono vecchi come la mercatura,
gli arabi vendevano il prodotto sotto un nome arabo bello ma deliberatamente
fuorviante: lo chiamavano "Luban Giaví", che significa
"incenso di Giava", benché il benzoino non fosse
propriamente un incenso, e benché esso non venisse affatto
da Giava.
In Italia e in Francia la prima sillaba è stata confusa con
l'articolo ed è caduta; quanto rimaneva del nome, cioè
Bangiaví, è stato pronunciato e scritto in vari modi,
fino a fissarsi in benzoé, beaujoin, benjoin, ed infine in
benzoino. Passarono altri secoli, finché nel 1833 un chimico
tedesco pensò per primo di sottoporre il benzoino alla distillazione
secca, cioè di scaldarlo fortemente in assenza d'acqua, in
una di quelle storte che ancora oggi compaiono qua e là come
simboli araldici della chimica, benché i chimici non le usino
piú. Si riteneva a quel tempo, piú o meno consapevolmente,
che questo trattamento servisse a separare la parte volatile, nobile,
"essenziale" di una sostanza (non per niente la benzina
si chiama tuttora "essence" in francese) dal residuo inerte
che rimaneva in fondo alla storta: che si trattasse insomma di una
separazione di un'anima da un corpo. In molte lingue, infatti, la
parola "spirito" designa sia l'anima, sia l'alcool e altri
liquidi che evaporano facilmente.
Il chimico tedesco ottenne cosí l'"anima", l'"essenza"
del benzoino, e la chiamò benzina: in effetti era il prodotto
che noi oggi chiamiamo benzene, ma con i mezzi analitici del tempo
non era facile distinguerlo dalla frazione del petrolio che ha all'incirca
lo stesso punto di distillazione e che oggi si chiama benzina; nei
primi decenni del secolo scorso i due nomi e i due prodotti erano
sostanzialmente intercambiabili, e del resto ancora oggi il benzene
potrebbe essere un buon surrogato della benzina se non fosse cosí
tossico. Molte automobili partigiane hanno viaggiato a benzene,
o con altri carburanti anche piú esotici e pericolosi, senza
danno evidente. E solo una curiosa coincidenza che si chiamasse
Benz l'uomo che nel 1885 costruí il primo motore a benzina
efficiente; a meno che il suo nome (che compare tuttora nella ragione
sociale della Mercedes) non abbia contribuito alla vocazione di
inventore dell'ingegner Karl Benz.
Ancora da una distillazione secca, e dall'intento di isolare l'essenza,
lo spirito del legno, prende inizio la storia del nome del metano.
Distillando a secco il legno si ottengono liquidi complessi, assai
diversi a seconda del legno da cui si parte, e comunque costituiti
in buona parte da acqua. Essi però contengono spesso una
piccola percentuale di quello che oggi si chiama alcool metilico.
Un altro chimico, questa volta francese, del secolo scorso purificò
questo "spirito di legno", ne descrisse le proprietà,
e si accorse che assomigliava molto al vecchio e noto "spirito
di vino": aveva aroma e sapore anche piú gradevoli di
quest'ultimo, ma se consumato anche in piccola quantità conduceva
alla cecità permanente, e qui si conferma che il grato odore
è una pessima guida. Probabilmente con l'aiuto di qualche
collega grecista, tradusse malamente "spirito di legno"
in "methy hyle", perché in greco hyle è
il legno, e methy indica genericamente i liquidi inebrianti (il
vino, l'idromele eccetera). Questo "methy" compare anche
nell'antichissimo nome dell'ametista: non a causa del suo colore
violaceo, ma perché si riteneva che questa gemma avesse la
proprietà di combattere l'ubriachezza.
Da "methy hyle" si trasse "alcool metilico",
e da questo il nome del metano, che gli è chimicamente vicino,
in base ad un primo rudimentale accordo fra i chimici di vari Paesi,
secondo cui si doveva riservare la desinenza -ano agli idrocarburi
saturi. Al metano hanno fatto seguito l'etano, dalla radice di "etere";
il propano, distorcendo un poco il greco "protos", cioè
"primo"; e il butano, dalla radice di "butirro",
che a sua volta trae origine da una parola greca che vuol dire "ricotta
di vacca". Gli altri idrocarburi saturi, pentano, esano, eptano
e cosí via, sono stati battezzati con meno fantasia ricorrendo
ai numerali greci che corrispondono al numero dei rispettivi atomi
di carbonio.
Un secondo linguaggio chimico, meno fantasioso ma piú espressivo,
è quello costituito dalle cosiddette formule gregge. Dire
che lo zucchero comune è C12H22011, o che il vecchio piramidone,
caro ai medici condotti, è C13H170N3, non ci indica nulla
sull'origine né sugli usi delle due sostanze, ma ne dà
l'inventano. E', appunto, un linguaggio greggio, incompleto: viene
a dire che per costruire una molecola di piramidone ci vogliono
tredici atomi di carbonio, diciassette d'idrogeno, uno d'ossigeno
e tre di azoto, ma non dice niente sull'ordine o sulla struttura
in cui quegli atomi sono legati insieme. Insomma, tutto va come
se un tipografo estraesse dalla cassetta le lettere c, e, i, o,
p, r, s, s, e pretendesse di esprimere cosi la parola cipresso:
il lettore non iniziato, o non aiutato dal contesto, potrebbe anche
"leggere" processi o scopersi o chissà quale altro
anagramma. E' una scrittura sommaria, che ha il solo pregio (tipografico
appunto) di stare bene nelle righe dello stampato.
Il terzo linguaggio ha tutti i vantaggi, e il solo svantaggio dovuto
al fatto che le sue "parole" nelle righe dello stampato
comune non ci stanno. Tende a (o pretende di) darci il ritratto,
l'immagine del minuscolo edificio molecolare: ha rinunciato a buona
parte del simbolismo che è proprio di tutti i linguaggi,
ed è regredito all'illustrazione, alla pittografia. E come
se, invece della parola cipresso, si stampasse o disegnasse l'immagine
del cipresso. Il sistema fa tornare alla mente quell'accademico
del paese dei Balnibarbi di cui parla Swift nei Viaggi di Gulliver:
secondo lui, si doveva ragionare senza parlare, e in luogo delle
parole egli proponeva di avere sottomano "ogni cosa su cui
cadeva l'argomento del discorso", cioè quello che oggi
si chiama il "referente": un anello se si parla di anelli,
una vacca se si parla di vacche, e cosi via. In questo modo, argomentava
l'accademico, "tutte le nazioni avrebbero potuto facilmente
intendersi fra loro". Non c'è dubbio che il linguaggio
oggettivo, anzi oggettuale, dei Balnibarbi, e le formule strutturali
dei chimici, si avvicinano alla perfezione sotto l'aspetto della
comprensibilità e dell'internazionalità, ma entrambi
presentano l'inconveniente dell'ingombro, come ben sanno gli infelici
compositori dei testi di chimica organica.
Naturalmente, a dispetto delle sue pretese ritrattistiche, e a differenza
dal Balnibarbo, il linguaggio delle formule di struttura, per il
fatto stesso di essere un vero linguaggio, è rimasto parzialmente
simbolico. In primo luogo, perché i suoi ritratti non sono
in grandezza naturale, bensi nella "scala" (cioè
nell'enorme ingrandimento) di circa uno a cento milioni. Poi, perché
in luogo della forma degli atomi essi contengono il loro simbolo
grafico, cioè l'abbreviazione del loro nome, e perché
fra gli atomi stessi si dimostra utile introdurre, e rappresentare
con trattini simbolici, le forze che tengono insieme gli atomi stessi.
Infine, per il motivo fondainentale, e valido per tutti i ritratti,
che l'oggetto rappresentato ha in generale uno spessore, ha una
struttura a tre dimensioni, mentre il ritratto è piatto perché
è piatta la pagina su cui deve essere stampato. Eppure, nonostante
tutte queste limitazioni, se si confrontano questi schemi convenzionali
con i ritratti "veri", quasi fotografici, che da qualche
decennio si riesce a fare con tecniche sottili, si rimane colpiti
dalla loro somiglianza: le molecole-parole, i disegnini ricavati
dal ragionamento e dall'esperimento, sono proprio assai simili alle
particelle ultime della materia che gli antichi atomisti avevano
intuito vedendo i granelli di polvere che danzavano in un raggio
di sole.
Primo Levi, Il sistema periodico,Torino: Einaudi, 1975, pp.
121-126.
|